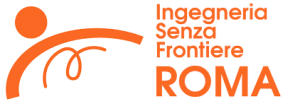Una giornata a Shatila

La prima volta che vedo il padre di Mujahed* mi ritrovo da qualche ora dentro una di quelle immagini stampate in riviste di approfondimento politico o appese in mostra, scattate da chi cerca di raccontare una storia, fotoreporter coraggiosi mossi dalla loro stessa natura, curiosità e passione. Catturato dalla fotografia ora posso focalizzare i dettagli, esplorare i soggetti, annusare l’aria, andare oltre i confini dell’immagine, girare lo sguardo e seguire il movimento della storia che assume la sua dimensione temporale.
Lui si aggira per la ‘piazzetta’ polverosa con un annaffiatoio in mano, movimenti lenti e misurati che gli consentono di non inciampare in quei piccoletti veloci ed imprevedibili che gli ronzano attorno come api. Un gruppetto di bambini c’è sempre in questo spazio. Non fanno altro che giocare, picchiandosi perlopiù o correndo dietro ad un pallone con le scarpette con i tacchetti che mai affondano nel suolo arido. Eppure sono in pochi ad esserne sprovvisti, in pochi rischiano di giocare senza, graffiano la terra danzando su quei tacchetti con una naturalezza sorprendente.
un annaffiatoio in mano, movimenti lenti e misurati che gli consentono di non inciampare in quei piccoletti veloci ed imprevedibili che gli ronzano attorno come api. Un gruppetto di bambini c’è sempre in questo spazio. Non fanno altro che giocare, picchiandosi perlopiù o correndo dietro ad un pallone con le scarpette con i tacchetti che mai affondano nel suolo arido. Eppure sono in pochi ad esserne sprovvisti, in pochi rischiano di giocare senza, graffiano la terra danzando su quei tacchetti con una naturalezza sorprendente.
In pieno agosto il suo abbigliamento può risultare singolare, scarpe chiuse, calze, pantaloni lunghi e scuri ma una camicia leggera a mezze maniche che restituisce il respiro in un clima così umido e caldo. Cammina immerso nel riverbero abbacinante della mattinata estiva, in quella luce che fa strizzare gli occhi e che per pochi secondi offusca la vista a chi esce dall’ombra. Di rado incontri quella luce. Lungo i vicoli del campo infatti puoi tranquillamente alzare lo sguardo al cielo, gli edifici addossati gli uni agli altri, già alti ma sempre con un piano ancora da costruire, i panni stesi ad asciugare e le fitte ragnatele di cavi elettrici permettono ai raggi del sole di toccare il suolo solo per pochi minuti al giorno.
Tra i sessanta ed i settanta, capelli folti e bianchi, occhi scuri, cerchiati da una stanchezza che viene da lontano, accumulata negli anni. Avvicinandomi la posso sentire, si fa densa e quando arrivo a stringergli la mano l’entusiasmo con cui mi sono svegliato in questa strana mattinata si nasconde tra le pieghe del mio stomaco, è inappropriato, non c’è spazio per la leggerezza delle mie ferie. Lo seguo dentro il portone d’ingresso della sua associazione, quattro piani affacciati sull’unico spazio aperto del campo, un rettangolo assolato di terra battuta strenuamente difeso dal cemento dal figlio di Abu e da chi, come lui, continua a coltivare il ricordo di orizzonti più ampi, capaci di riposare gli occhi. Al limitare della piazzetta, su due lati, sorgono delle alte recinzioni che apparentemente non racchiudono un bel niente. A guardar meglio però rimango colpito da quelle due strette gabbie senza soffitto. Sorvegliano delle piante, una manciata di giovani e determinati alberi di ulivo che affondano le loro radici nella terra assetata, da cui affiorano sovente detriti e calcinacci. Sono rare le piante in questo chilometro quadrato, rarissime.
Il padre di Mujahed  posa l’annaffiatoio ed infila il corridoio, c’è un odore familiare che risveglia immagini di altre esperienze vissute lontano da casa. Non so cosa sia ad avere questo odore, non l’ho mai saputo, sono curioso ma lascio solamente che i ricordi affiorino e scorrano nitidi nella mia mente, sorrido. Seguo i miei compagni di spedizione in un ufficio silenzioso, ventilatori, pc, stampanti…tutto spento, in questa fascia oraria la corrente elettrica non c’è, dovrebbe tornare alle 14….dovrebbe. Ci sediamo ed accettiamo curiosi una tazza di caffè, mi domando secondo quale tradizione sia preparato, libanese? palestinese?, è bollente ed è meglio aspettare che i fondi si depositino è acre e polveroso. E’ tarda mattinata ed Abu si siede e ci fa accomodare. Stringe tra le dita l’incontro tra naso e fronte, strizza gli occhi e ci osserva per qualche istante. Ci sta chiedendo senza parlare che ci facciamo lì, cosa stiamo cercando in quell’angolo sperduto di mondo, cosa vogliamo dimostrare. La sua domanda non vuole risposta, non ora, ci concede tempo, ma questo interrogativo mi risuona dentro, cosa sto cercando, che ci faccio lì?
posa l’annaffiatoio ed infila il corridoio, c’è un odore familiare che risveglia immagini di altre esperienze vissute lontano da casa. Non so cosa sia ad avere questo odore, non l’ho mai saputo, sono curioso ma lascio solamente che i ricordi affiorino e scorrano nitidi nella mia mente, sorrido. Seguo i miei compagni di spedizione in un ufficio silenzioso, ventilatori, pc, stampanti…tutto spento, in questa fascia oraria la corrente elettrica non c’è, dovrebbe tornare alle 14….dovrebbe. Ci sediamo ed accettiamo curiosi una tazza di caffè, mi domando secondo quale tradizione sia preparato, libanese? palestinese?, è bollente ed è meglio aspettare che i fondi si depositino è acre e polveroso. E’ tarda mattinata ed Abu si siede e ci fa accomodare. Stringe tra le dita l’incontro tra naso e fronte, strizza gli occhi e ci osserva per qualche istante. Ci sta chiedendo senza parlare che ci facciamo lì, cosa stiamo cercando in quell’angolo sperduto di mondo, cosa vogliamo dimostrare. La sua domanda non vuole risposta, non ora, ci concede tempo, ma questo interrogativo mi risuona dentro, cosa sto cercando, che ci faccio lì?
Qualche mese fa sono inciampato in un ampio progetto di collaborazione tra CYC, un associazione palestinese che lavora in diversi campi profughi palestinesi in Libano “per garantire ai giovani un’educazione basata sul gioco e sul diritto di espressione, sviluppata attraverso le proprie abilità e la propria immaginazione” ed ISF, un’associazione italiana di volontariato li cui nobile scopo è quello di elaborare, realizzare e diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche in grado di favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità umane. E’ successo tutto molto semplicemente, “stiamo lavorando per realizzare un progetto che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’associazione palestinese che lavora in Libano, a Beirut. Avere con noi qualcuno che abbia esperienza sul campo ci sarebbe di aiuto, che ne dici?”. Stimolante, credo di non averci pensato affatto…ed ora il padre di Mujahed mi stava chiedendo di farlo.
Quella sera, dopo una calda giornata di lavoro, conosco Mohammed, è palestinese anche lui, ha studiato all’università americana di Beirut, fa il farmacista e non vive più nel campo. Ha anche una macchina e ci scarrozza per la città verso quei quartieri della città ritratti nelle schiere di cartelloni pubblicitari che campeggiano in aeroporto. A Beirut oggi si fanno affari, dopo la guerra civile la città ha vissuto una delle più imponenti opere di ricostruzione mai viste, in gran parte ventilata dall’allora primo ministro Hariri, padrone di un impero finanziario fondato sull’edilizia e morto ammazzato nel 2005.
 Il lungomare saluta i naviganti con una schiera di alte torri di cemento, alberghi ed appartamenti di lusso moneta di scambio per i ricchi petrolieri del golfo. ‘Downtown’ è in gran parte pedonale, presidiata, i varchi di accesso sono controllati dai kalasnikof al braccio dei militari, se vuoi entrare lo zainetto ti viene perquisito. Le strade sono pulite, vuote, qualche turista che si aggira col naso all’insù, l’architettura è curata, bello, non c’è che dire.
Il lungomare saluta i naviganti con una schiera di alte torri di cemento, alberghi ed appartamenti di lusso moneta di scambio per i ricchi petrolieri del golfo. ‘Downtown’ è in gran parte pedonale, presidiata, i varchi di accesso sono controllati dai kalasnikof al braccio dei militari, se vuoi entrare lo zainetto ti viene perquisito. Le strade sono pulite, vuote, qualche turista che si aggira col naso all’insù, l’architettura è curata, bello, non c’è che dire.
Il nuovo Souk non ha odore, è asettico, la sterilità delle carte di credito s’è portata via tutto il fascino che la parola ‘souk’ evoca. Un cinema multisala psichedelico e più di 200 larghi e comodi negozi condizionati, le luci bianche mettono in mostra le più blasonate firme del globo. Nel ‘mercato’ non c’è più spazio per i colori, per i cesti pieni di spezie, per i banchi ricolmi delle merci più disparate. Ciò che rimane è il più autentico dei centri commerciali.
Sono stanco, disorientato, ho perso il filo. Ho bisogno di riflettere, o forse no. La risposta è lì, la conosco già, l’unico mondo che posso cambiare è dentro di me e vivere momenti speciali da cui trarre una crescita è ‘il perché’. Il concetto è molto semplice, forse banale per qualcuno, ma tutto acquista un senso nel momento in cui non trovo più domande a cui rispondere, non sento più voci che chiedono di essere ascoltate, sono uno.
Dal tetto della ‘guest house’ che mi ospiterà in questi giorni la periferia sud di Beirut è uniformemente grigia ed i confini di Shatila si possono distinguere dall’altezza degli edifici che vi sorgono. Negli ultimi anni la popolazione è aumentata, raddoppiata a seguito delle vicende in Siria, e lo spazio del rifugio è stato guadagnato in altezza. A tratti il pavimento del terrazzo è ricoperto da croste di sale, dai rubinetti esce acqua salata, di mare; non sempre però, il servizio non è garantito e le cisterne che popolano numerose i tetti dei palazzi ne sono la diretta conseguenza.
 Una dozzina di piccioni sorvola in gruppo il quartiere, girano in cerchio, come telecomandati. Che strano, sono liberi di volare ovunque ma continuano ad aggirarsi in questo lattiginoso tratto di cielo, li seguo ed in breve l’interrogativo si scioglie. C’è un ragazzo che da uno dei tetti continua ad agitare uno straccio legato all’estremità di un lungo bastone, il suo bizzarro comportamento è legato al volo degli uccelli, rispondono ai suoi gesti, sono allevati qua, sui tetti di Shatila.
Una dozzina di piccioni sorvola in gruppo il quartiere, girano in cerchio, come telecomandati. Che strano, sono liberi di volare ovunque ma continuano ad aggirarsi in questo lattiginoso tratto di cielo, li seguo ed in breve l’interrogativo si scioglie. C’è un ragazzo che da uno dei tetti continua ad agitare uno straccio legato all’estremità di un lungo bastone, il suo bizzarro comportamento è legato al volo degli uccelli, rispondono ai suoi gesti, sono allevati qua, sui tetti di Shatila.
Sono sempre rimasto affascinato dal richiamo alla preghiera che rimbalza da un minareto all’altro nelle città islamiche. Il canto del Muezzin alle prime luci dell’alba non segue l’orologio ma varia in base alla posizione del sole, rompe il silenzio del mattino ed abbatte le distanze della metropoli. Se ad Istanbul il richiamo del mattino desta il coro di ululati e guaiti dei cani randagi, qua le mattine cominciano un po’ prima, con il canto del gallo. Non è una barzelletta, è sbalorditivo, da qualche parte nel quartiere devono vivere dei galli, magari anche delle galline e chissà quali altri animali da ‘cortile’. Le prime volte era istintivo lo slancio ad affacciarsi alla finestra per cercarli, ma subito lo sguardo urtava contro le mura dell’edificio di fronte, lì a portata di braccio.
La capacità di adattamento di alcune specie ad habitat a dir poco ‘innaturali’ è sorprendente, l’essere umano non è da meno, la storia testimonia, e Shatila non è di certo il più estremo degli esempi.
 [Sono sempre stato portato a pensare che dove avessi incontrato genti accomunate da condizioni di vita difficili avrei trovato coesione…se l’unione fa la forza a Shatila ne serve parecchia. Qua, ogni giorno, per acquisire ciò che a me è sempre stato dato come un semplice servizio, garantito, qualche euro il suo valore, le energie spese sono tante, e senza cacciar fuori paroloni ad effetto può calzare il paragone con le immagini ed i frammenti che escono dai film di qualche decade fa, o dai racconti dei miei nonni, mani dure, callose, scarpe vecchie, logore, strade polverose e sporche, rifiuti (quelli di una volta però). Da queste generazioni ho sentito parlare di miseria e sempre da loro ho ‘imparato’ il concetto di comunità, parola che oggi suona più vuota che mai. L’era della rete non è altro che l’era dell’individuo, il concetto di libertà assume per assurdo dei colori grigi, freddi, tutto ti è concesso, prendi ciò che vuoi, tanto tutto puoi dimenticare, nessuno ha il diritto di ricordarti il passato!! Una volta la comunità non dimenticava, certo, erano i valori condivisi che dettavano le regole, sbagliati o no, ci si doveva muovere di conseguenza. Conoscendo il padre di Mujahed, uomo dalla storia cinematografica, che non ha mai smesso di combattere per ciò in cui crede, per la sua gente, ieri abbracciando il fucile, oggi cercando di dare ai bambini di Shatila degli spazi al di fuori della strada sommersa dai rifiuti, <<perché>>, dice, <<se cresci tra i rifiuti cos’altro puoi diventare?>>, sento che anche qua, negli ultimi anni, la parola comunità sta perdendo, ha perso, la sua forza….il sistema globale sembra essere autoimmune, i meccanismi di disgregazione riescono ad entrare laddove nemmeno il sole filtra tanto i palazzi sono stretti l’uno all’altro, laddove le piante si contano sulle dita di una mano e non cresce nemmeno un filo d’erba…
[Sono sempre stato portato a pensare che dove avessi incontrato genti accomunate da condizioni di vita difficili avrei trovato coesione…se l’unione fa la forza a Shatila ne serve parecchia. Qua, ogni giorno, per acquisire ciò che a me è sempre stato dato come un semplice servizio, garantito, qualche euro il suo valore, le energie spese sono tante, e senza cacciar fuori paroloni ad effetto può calzare il paragone con le immagini ed i frammenti che escono dai film di qualche decade fa, o dai racconti dei miei nonni, mani dure, callose, scarpe vecchie, logore, strade polverose e sporche, rifiuti (quelli di una volta però). Da queste generazioni ho sentito parlare di miseria e sempre da loro ho ‘imparato’ il concetto di comunità, parola che oggi suona più vuota che mai. L’era della rete non è altro che l’era dell’individuo, il concetto di libertà assume per assurdo dei colori grigi, freddi, tutto ti è concesso, prendi ciò che vuoi, tanto tutto puoi dimenticare, nessuno ha il diritto di ricordarti il passato!! Una volta la comunità non dimenticava, certo, erano i valori condivisi che dettavano le regole, sbagliati o no, ci si doveva muovere di conseguenza. Conoscendo il padre di Mujahed, uomo dalla storia cinematografica, che non ha mai smesso di combattere per ciò in cui crede, per la sua gente, ieri abbracciando il fucile, oggi cercando di dare ai bambini di Shatila degli spazi al di fuori della strada sommersa dai rifiuti, <<perché>>, dice, <<se cresci tra i rifiuti cos’altro puoi diventare?>>, sento che anche qua, negli ultimi anni, la parola comunità sta perdendo, ha perso, la sua forza….il sistema globale sembra essere autoimmune, i meccanismi di disgregazione riescono ad entrare laddove nemmeno il sole filtra tanto i palazzi sono stretti l’uno all’altro, laddove le piante si contano sulle dita di una mano e non cresce nemmeno un filo d’erba…
Che poi, quando qualcosa lo conosci solo per sentito dire, non lo capisci mai veramente.
(Dalle impressioni di viaggio di Valerio Vespasiani)
* Abu Mujahed, che in arabo significa appunto “il padre di Mujahed”, è il nome con cui tutti a Shatila chiamano Mohammed Abbas, il responsabile del CYC.